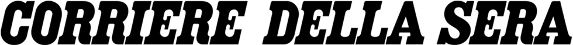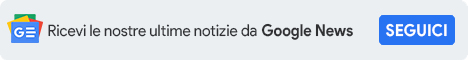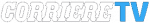
«Mi chiedeva lo sconto», «sono suo cugino», ecco chi c’era ai funerali di Valentino: il videoracconto

Attualità Mercoledì 22 Giugno 2016 ore 18:30
"Sindaca Ceccardi?" No, chiamatemi sindaco

Così la pensa la neo eletta a Cascina, ma le altre prime cittadine hanno opinioni diverse. La versione della linguista pontederese Cecilia Robustelli
CASCINA — E' l'uso il vero maestro, diceva uno scrittore cinquecentesco fra i fondatori dell'Accademia Fiorentina, tale Pier Francesco Giambullari. E allora, dopo il recente risultato elettorale che ha visto trionfare molte donne e fra le altre la leghista Susanna Ceccardi nella “rossa” Cascina, sembra più che mai giusto porsi un interrogativo linguistico per restare al passo coi tempi: si dice sindaco o sindaca?
Ma se Ceccardi più volte in campagna elettorale ha ribadito che vuole essere chiamata sindaco, della stessa opinione non sembrano essere le altre colleghe dei comuni pisani. Si va infatti dalla prima cittadina di Capannoli Arianna Cecchini che usa i termini di sindaca e consigliera anche nelle comunicazioni istituzionali alla stampa, fino alla collega di Calcinaia Lucia Ciampi che invece si pone a metà strada, spiegando: "Condivido la battaglia del femminile, ma per quanto mi riguarda ancora non sono pronta ad accogliere appieno il cambiamento, non per mancanza di rispetto nè per inconsapevolezza dell'evoluzione linguistica, ma per un mio personale rimanere ancorata ad abitudini grammaticali e lessicali che vengono da lontano".
La vittoria leggendaria – com'è stata da molti, Lega in primis, definita – della “ragazzetta” dalla maglia verde e delle grilline Raggi e Appendino, inevitabilmente stimola una riflessione politica e culturale. Della ribalta delle donne in un settore finora in gran parte maschile come quello della politica e della necessità di modificare anche il nostro abitudinario uso dei termini legati a questi ambiti, ne abbiamo discusso con la Cecilia Robustelli, pontederese, collaboratrice dell'Accademia della Crusca e docente di linguistica all'Università di Modena e Reggio Emilia.
Professoressa,
lei più volte ha ribadito la necessità di cominciare
a inserire nel nostro dizionario del quotidiano termini come
ministra, sindaca, assessora. Perché finora non venivano usati
e perché invece dovremmo iniziare a farlo?
“I
nuovi ruoli istituzionali e le professioni prestigiose che vedono
oggi protagoniste le donne testimoniano un'innovazione
della società
dal punto
di
vista culturale
e professionale.
E
per
descrivere una
società
nuova servono parole nuove: in questo caso serve anche la
forma
femminile di termini prima usati solo al
maschile perché,
effettivamente,
riferiti
agli uomini”.
A
molti però
questa sorta di adeguamento linguistico alla società in
evoluzione non sembra suonar bene...
“In
realtà, quello di declinare al femminile i termini è un
comportamento
adottato
comunemente nella vita quotidiana. Parliamo
infatti di pasticciera,
maestra, ragioniera.
Non vedo quindi nulla
di male nel
dire
anche
consigliera, sindaca,
ministra o
chirurga. Anzi. Le obiezioni
che
vengono fatte
al
riguardo
non
hanno senso,
possiamo
farlo senza alcuna esitazione perché è una nostra
normale
abitudine. Non
siamo noi a imporlo, è la lingua italiana che ci chiede di
usare il femminile per definire le donne”.
Eppure,
sia nel parlato che nello scritto, sulla stampa così come
negli atti amministrativi, l'uso preponderante sembra essere quello
del maschile, come se fosse un genere neutro che va bene anche per il
femminile. Si può intendere così?
“Non
nascondo che in alcuni casi, ambiti e documenti specifici possa
sembrare difficile riferirsi in modo paritario a donne e uomini, e
per imparare serve un'apposita formazione linguistica. Nell'attesa, è
opportuno riflettere sul fatto che il
genere grammaticale dei termini che si riferiscono a uomini e donne
non si può scegliere liberamente. La lingua italiana, come le
altre lingue, assegna il maschile alle persone di sesso maschile e il
femminile alle persone di sesso femminile. Una prova? Se dico il
professor X
in riferimento a una donna evoco in chi mi ascolta o mi legge
l'immagine mentale di un uomo, non di una donna. Inoltre,
il fatto di affiancare, al plurale, i termini femminili a quelli
maschili, fa sì che le donne si sentano incluse nella
comunicazione. La televisione che si rivolge a signori
e signore o
il Papa che parla a fratelli
e sorelle,
sono la dimostrazione che con un
dettaglio
linguistico si acquista una diversa capacità di raggiungere le
persone stesse”.
Anna Dainelli
© Riproduzione riservata
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI