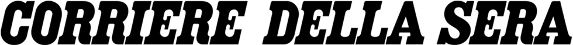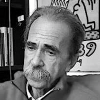Ottantanove
di Pierantonio Pardi - Martedì 18 Novembre 2025 ore 08:00
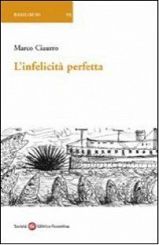
89 modi di raccontare la realtà, con contaminazioni di Wittgenstein, Manganelli e Carver.
Contaminazioni che ho trovato io e che motiverò strada facendo, addentrandomi nel bosco narrativo, ricco di imprevedibili sentieri che offre questo originalissimo libro di racconti di Marco Ciaurro.
[GALLERY(0)]
Ma iniziamo, come di consueto, dalla quarta di copertina:
Una lunga cavalcata nella cultura occidentale, fatta con microracconti di poche righe. Una forma letteraria poco usata in Italia e per questo nuova, vitale, brillante. Questo libro usa tutti i registri narrativi, dall’invenzione alla cronaca, dall’autobiografia al racconto filosofico, fino alla prosa poetica, con una scrittura asciutta, piena di senso e ironia.
In queste brevissime storie si incrociano destini umani, si addensano riflessioni ultime. Il bello si scopre nella compattezza di una scrittura frugale, sempre lucida e impietosa, dove la morte va spesso incontro ai protagonisti in modo paradossale e ambiguo. Perché la vita è più complessa
Delle nostre memorie e l’esistenza mal sopporta la riducibiltà alla netta comprensione.
Ed aggiungo a questa l’ottima recensione di Liliana Di Ponte (in “Letteratura”, 16 luglio 2009)
Che cos’hanno da spartire un intellettuale suicida perché non riesce più a scrivere e tre amici che si rivedono dopo anni e scoprono di non avere nulla da dirsi? E un uomo che assiste impotente ad un annegamento e una carpa asiatica che, disturbata dal rumore, salta fin sui battelli per mordere i viaggiatori? Che cosa accomuna la felicità di una bambina che finalmente può avere tutta per sé, in carcere, la madre prostituta e la delusione di un uomo che attraversa mezzo mondo per un appuntamento a cui l’amata non si presenta? Questi, e tanti altri personaggi, affollano la raccolta di racconti/flash di Marco Ciaurro, L’infelicità perfetta, con illustrazioni di Maddalena Duranti, Società Editrice Fiorentina, appena pubblicata. Sono microstorie, apparentemente slegate tra loro, che fissano, con la velocità di uno scatto fotografico, frammenti di una realtà multiforme e in continuo movimento, osservata con uno sguardo disincantato e descritta con una scrittura asciutta ed incisiva. Storie di gente comune e di personaggi borderline, colti in quella sottile linea di confine tra ciò che è ormai passato e quanto ancora può succedere, ognuno perso in un sogno o in una disperazione, tutti in qualche modo consapevoli dell’”infelicità perfetta” della condizione umana.
Ma veniamo adesso alle “contaminazioni” cui accennavo prima e iniziamo a raccontare il libro, partendo dal titolo: “L’infelicità perfetta” sembrerebbe a prima vista un ossimoro, perché la perfezione è sintomo di armonia e compiutezza e quindi opposta all’infelicità. Potrebbe essere un paradosso o l’utopia di un masochista: raggiungo la perfezione solo se sono infelice. Insomma, Ciaurro, che è un filosofo, ci provoca già a partire dal titolo.
Montale scriveva: “L’uomo coltiva la propria infelicità per avere il gusto di combatterla a piccole dosi. Essere sempre infelici, ma non troppo, è condizione sine qua non di piccole e intermittenti felicità”
Va bene, ma che c’entra Wittgenstein?
Per Wittgenstein, l'infelicità può essere vista come l'incapacità di percepire la felicità intrinseca nel mondo e nella vita, derivante dal non riuscire a vivere nel presente e da una visione del mondo esterna e materiale, invece che come un fatto mistico ed etico. Il mondo dell'infelice è qualitativamente diverso da quello del felice, poiché quest'ultimo non vede la felicità come qualcosa da raggiungere esternamente, ma come una condizione del proprio essere.
Un esempio paradigmatico di infelicità ce lo fornisce proprio lo scrittore che apre la raccolta (Il rebus dello scrittore)
Erano anni che lo scrittore apriva e chiudeva la penna senza riuscire a comporre una sola riga. Apriva e chiudeva la penna e anche quella volta la richiuse come la richiudeva sempre per soffocamento, per consueta mancanza di ispirazione.(…) Fu trovato impiccato a un enorme tiglio nel giardino della sua villa a Nonantola, dove viveva insieme al padre paraplegico.
E ancora, in un altro racconto (La moglie dello scrittore):
La signora stava tranquilla in cucina a preparare la cena. Lo scrittore prima la offese dicendole che portava sfiga, dopodiché prese la macchina da scrivere a pedate e poi la tirò di sotto in piazza Alighieri perché si era inceppato un tasto.
La morte e l’imprevisto sono due topoi di questi racconti; ci sono ben ventidue morti (impiccati, ammazzati anche in modo atroce, con un occhio strizzato allo splatter), come se la morte attraversasse in modo trasversale molte di queste storie. Ora, nel caso del racconto “La moglie dello scrittore” l’imprevisto è dato dall’incepparsi di un tasto, ma in altri racconti si manifesta sotto altre vesti.
C’è da fare una riflessione sull’imprevisto che per Wittgenstein è legato al concetto di “gioco linguistico” e alla resistenza e all’attrito incontrati dal linguaggio stesso e dal nostro agire nel mondo. Non c’è un concetto specifico di imprevisto, ma piuttosto l’idea che il linguaggio sia un’attività intrinsecamente legata alla pratica e alla forma di vita dove l’automatismo della pianificazione può essere interrotto da fattori inattesi, creando discontinuità, come succede in “Corsa incontro all’amata”:
Aveva preso due treni un aereo e un taxi poi corse a piedi fino alla caletta, dall’altra parte della collina, dove lei l’aspettava. Ma lei non c’era. Lui , dopo un bagno in mare, si girò a culo ritto e ritornò indietro da solo.
Oppure, come in “Un bacio infinito”
Dirimpetto al bar dell’ Ussero, sul lungarno, mentre si baciavano sotto un lampione, nello stringerla troppo forte a lui la soffocò, eppure senza volerlo le tolse il respiro, l’ultimo.
Giorgio Manganelli, poi, mi è venuto in mente, perché, leggendo quello che lui stesso scrive del suo romanzo “Centuria – Cento piccoli romanzi fiume” ho trovato alcune corrispondenze con il libro di Ciaurro. Ecco cosa scrive Manganelli:
Il presente volumetto racchiude in breve spazio una vasta ed amena biblioteca; esso infatti raccoglie cento romanzi fiume, ma così lavorati in modi anamorfici, da apparire al lettore frettoloso testi di poche e scarne righe. Dunque, ambisce ad essere un prodigio della scienza contemporanea alleata alla retorica, recente ritrovamento delle locali Università. Libriccino sterminato, insomma; a leggere il quale il lettore dovrà porre in opera le astuzie che già conosce, e forse altre apprenderne: giochi di luce che consentono di leggere tra le righe, sotto le righe, tra le due facce di un foglio, nei luoghi ove si appartano capitoli elegantemente scabrosi, pagine di nobile efferatezza, e dignitoso esibizionismo,
L’elemento che accomuna Ciaurro e Manganelli è dato dal fatto che entrambi usano il linguaggio per dimostrare che il suo uso non ha uno scopo idealistico o trascendente, ma è uno strumento comparativo e differenziato che ha un valore pragmatico, che dipende, cioè dal suo uso e dal contesto della narrazione.
Ed è, guarda caso, quanto sostiene l’amico attore nel racconto “Amicizia di un attore”
La sua peculiarità consisteva nel parlare sempre e in continuazione su tutto benché non dicesse nulla, ma sosteneva continuamente che per lui la parola rappresentava una cosa a priori dalla messa in scena. Diceva che la lingua dell’uomo esiste senza difficoltà come “un oggetto di studio eufonico”.
Il linguaggio, nell’infinita varietà dei suoi registri, diventa nei racconti di Ciaurro e di Manganelli un personaggio, il deus ex machina che manipola a suo piacimento il corso degli eventi, lasciando spesso, e in questo trovo analogie con Raymond Carver, spazio all’interpretazione del lettore con finali misteriosi e situazioni ambigue che invitano a riflettere e l’altra analogia con Carver riguarda lo stile: Ciaurro utilizza un linguaggio semplice e diretto, minimalista, evitando descrizioni superflue e concentrandosi sull’essenziale, contribuendo a creare un’atmosfera di inquietante realismo.
Concludo con il racconto (“Inno alle parole”) che chiude la raccolta e che rappresenta, a mio avviso, l’elogio dell’imprevisto paradossale, intriso di ironia o, meglio dell’Humour noir alla Bréton:
Un bambino basso, brutto e viziato si inventò, o meglio ebbe la capacità di inventarsi enfant prodige per piacere alla zia, alla nonna, alla mamma ma soprattutto al nonno, il signor Schweitzer, il quale, per tutta risposta, pensò bene, e forse a ragion veduta, di fargli capire che egli “era un idiota”. Il nonno, magari, non aveva visto male, ma il bimbo, l’idiota della famiglia, si intestardì e diventò Jean Paul Sartre.
L’autore
Marco Giuseppe Ciaurro, nato nel 1964, ha studiato e collaborato con Aldo Gargani all’Università di Pisa e con Jaques Derrida all’Ecole des Hautes Etude a Parigi. È membro della Societé Amie de Blanchot e del Comitié de rèdaction nel sito Espace Maurice Blanchot. Al suo attivo romanzi e racconti: La stanza dei fili (Firenze, 2000), L’infelicità perfetta (Firenze 2009). Ha curato il saggio filosofico (edizione italiana) di La questione degli intellettuali. Abbozzo di una riflessione di Maurice Blanchot (Milano-Udine 2011).
Pierantonio Pardi