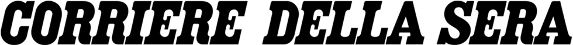PRIMO
di Marco Celati - Martedì 18 Marzo 2025 ore 08:00

Sono in sala d’aspetto. È in fondo al corridoio: luci al neon, poche poltroncine davanti all’ascensore. Una porta si apre e si chiude nel via vai, ma da un po’ è scesa una calma surreale. È il mio turno e aspetto. Del resto in una sala di aspetto, si aspetta. Non c’è altro che si possa fare. A volte penso che la vita sia attendere qualcuno, qualcosa, sperare in momenti migliori, ricordarci chi siamo.
Mi chiamo Fabrizio, sono stato un operaio, un piaggista. Poi un pensionato, meglio -anzi peggio- un esodato, dopo la riforma pensionistica della Fornero, Governo Monti. Ci pianse quando la illustrò. La Fornero, non Monti. C’ho pianto più io. Anche allora ho dovuto aspettare. Parecchio. Alla fine in pensione ci sono andato. Ora aspetto, ma con trepidazione. Però il tempo è relativo e mi innervosisce, fa così quando si dilunga. Allora penso, ricordo, provo ad ingannarlo il tempo, perché lui non inganni me.
Il mio papà, cioè colui che sarebbe diventato il mio papà, si chiamava Primo. Lo so, qui dicono babbo e dire papà sembra lezioso, maledetti, benedetti toscani! Ma noi veniamo dal nord e per me papà era papà. Mia figlia, nata qui, dice babbo. Papà Primo era del 1909, all’inizio del secolo. Allora i figli venivano così -quelli che ce la facevano e le madri pure- e a volte gli davano nomi come di un elenco: Primo, Secondo, Ultimo. Era di Casale Monferrato, piemontese. Diciottenne, va al servizio militare. La leva obbligatoria era stata ridotta a due anni, che comunque erano sempre tanti per la vita e il bisogno della gente. Ritorna a casa, a Casale. In famiglia ci sono quattro sorelle più piccole, un padre malandato, casellante delle ferrovie e tanta povertà. Le sorelle erano, in ordine di nascita, Mafalda, Itala, Iolanda e Velia. Mafalda, la maggiore, aveva diciotto anni, le altre tutte a scalare. Siamo nel 1929, VII anno dell’era fascista, nientepopodimeno, e viene contattato da un gerarca del posto. Questo tizio gli dice: Primo, te mi risulta che al militare aggiustavi i camion, se prendi la tessera ti mettiamo alla FIAT, reparto motori. Mio padre era un uomo mite e non gli piacevano i fasci italiani di combattimento e, mitemente, rispose, no grazie, come avessi accettato.
Così andò a Torino a pulire i cessi della Stazione: dieci ore di lavoro, cinque la mattina e cinque la sera. Partiva presto col buio, a pranzo mangiava un pezzo di pane e formaggio su una panchina e col buio ritornava, la sera tardi. Da Casale a Torino, andata e ritorno in treno, erano cinque ore di viaggio. Tre mesi questa vita. Poi cominciò a balenargli un’idea in testa. Aveva uno zio, ex carratore dagli occhi tristi, il quale gli diceva, ogni volta che lo vedeva, che sbaglio ho fatto quando Aristide, un amico, mi chiese di fare una società per costruire le ruote delle macchine prodotte dalla Fabbrica Italiana di Automobili! Nel 1899, a Torino nasceva la società anonima che poi divenne la Fiat. Che sbaglio! Io non ci credevo, pensavo che il cavallo fosse insostituibile. Bisognava avergli detto, consolati zio, sembra che il grande finanziere Cuccia non avesse previsto nessun futuro per il computer, era rimasto alla macchina da scrivere. Ma questo è un pensiero dei tempi nostri, del futuro, e lo zio non poteva saperlo. Perciò forse era inconsolabile e aveva gli occhi tristi.
- Ciao Primo, che c’è?
- Zio, saresti in grado di costruire dei piccoli calessi a due posti per bambini?
- Certo, facevo carri bestiame e calessi da corsa, vuoi che non te li sappia fare! Però ci vogliono materiali buoni, come stai a soldi?
- Male, ma da domani vado garzone da un fotografo, mi metterà allo sviluppo con gli acidi e ha detto che mi pagherà.
La domenica dopo, sapeva di un falegname che costruiva cavalli a dondolo per bambini, e lo andò a trovare. Gli chiese se poteva fargli sei asinelli in legno alti un metro. Poi a dipingerli ci penserò io. Soldi non ne aveva, però il falegname era una persona buona e Primo si dimostrava per quel che era: un bravo giovane che aveva una famiglia pesante sulle spalle. Il mio papà gli disse dell'idea e il vecchio falegname fu entusiasta che la sua maestria fosse ancora apprezzata. Così, nel giro di qualche mese, Primo riuscì a costruire una giostra con asinelli e calessini. Misurava dieci metri circa di diametro, era azionata da un motore elettrico regolato da un reostato che lui stesso aveva costruito. Era diventato un giostraio. Alla fiera di Casale Monferrato in tre giorni riprese tutte le spese, un successone! Tanti bambini e corse senza sosta, dalla mattina alla sera. Dicevano, si va sui “ciuchini”! I giostrai sono genio, cuore, fantasia. Sono avventurieri con animo di fanciulli.
Ora doveva e forse poteva pensare alle sorelle. Erano giovani, non bellissime -non si dovrebbe dire- ma giovani. Sennonché, siamo nel 1935, l’Italia fascista, in barba alla Società delle Nazioni, aveva sete di impero coloniale da far riapparire "sui colli fatali di Roma", come disse il Duce, arringando la folla. “Ne sarete voi degni?”. E la folla: “Si!!!”. La guerra, anzi la campagna di Etiopia era alle porte. Così papà lo richiamarono alle armi. Si ritrova a Mogadiscio e da lì, con una colonna di rifornimento, partono su sei camion Fiat, tremila di cilindrata, tre assi, a benzina con una autonomia di circa duecento chilometri. Così almeno credo di ricordare dai racconti di mio padre, dopo tanti anni. I suoi ricordi sono frammentari e non è stato facile ricomporre tutti i passaggi. Anche se, a proposito di questa fase della vita, lui era più sereno, lucido e non piangeva come quando, a tratti, mi raccontava degli eventi successivi e della deportazione.
Intanto si è fatto tardi, sono venuto a casa. C’è mia moglie, ci sono i due nipotini. Sprofondo nella mia poltrona preferita, chiudo un poco gli occhi. Ancora niente? No -rispondo- bisogna aspettare. E, insieme a loro, continuo ad aspettare e, mentre aspetto, a ricordare.
I “nostri” dovevano attraversare il deserto per portare le munizioni ad un avamposto italiano. Lungo il tragitto, in una gola, su in alto, apparvero delle truppe: misere, pochi cammelli con casse di bombe a mano che iniziarono a lanciare sulla colonna. Noi, tutti sotto i camion per evitare le granate, che però non esplodevano. Forse erano da addestramento o non funzionanti, difettose. Oppure non erano capaci di togliere la sicura. Fatto sta che avevamo armi, nonché munizioni sufficienti e mettemmo in fuga le povere truppe cammellate del nemico. Che comunque, quella era casa loro e noi eravamo là come invasori, mandati da un regime che, in molti, non condividevamo, costretti a servire una causa sbagliata e disumana. Per la notte ci fermiamo vicino a un’oasi. Turni di quattro ore. Papà era stanco dal viaggio, lui era autista e non c’era il servo sterzo allora. Guidare, e poi su quelle piste sabbiose, era molto faticoso. Il tenente lo mise di sentinella le prime quattro ore, poi quattro di riposo e altre quattro di sentinella. Per dormire, perché di giorno faceva molto caldo e la notte freddissimo, si infilava nel sacco a pelo e, quando pidocchi o altri insetti si muovevano, usciva dal sacco, lo girava e lo scuoteva. Così riusciva a prendere sonno. In quella zona girava voce di una tribù che, quando catturavano i nemici, li legavano a una palma, nudi, gli tagliavano l’uccello, glielo mettevano in bocca e li lasciavano morire dissanguati o aggrediti dalle iene. Quella notte, al primo turno di sentinella, papà chiama il tenente. Lo chiamò perché dalla rada boscaglia dell'oasi si intravedevano degli occhi che la luna faceva brillare. Impaurito dalla storia del taglio degli attributi, dette l’allarme. Erano iene! Nel senso degli animali. La notte proseguì inquieta, in quell’oasi, in quel deserto immenso, tra le dune, al chiaroscuro lunare. La mattina presto la colonna mosse per Addis Abeba, la capitale etiopica.
Dopo due ore di deserto una tormenta di sabbia li blocca. La tempesta sembra non smettere mai, si protrae fino a notte. Dormono con una maglia bagnata avvolta in testa e sul viso, per respirare meno sabbia possibile. La mattina si ritrovano con una duna enorme, un monte davanti alla pista. Il cartografo allora individua la traccia di un altro percorso, un chilometro dietro di loro. Alla meglio peggio, con gomme sgonfiate, tavole e verricelli per avanzare sulla sabbia, arrivano alla nuova pista, che però è più lunga. Dopo quattro ore di viaggio, tre mezzi restano senza benzina e gli altri tre ne hanno solo per dieci chilometri ancora. La destinazione è assai più lontana. Decidono di non dividersi e aspettare i soccorsi. Il marconista aveva lanciato la richiesta di aiuto, ma dopo due giorni, niente. L’acqua stava ormai finendo e così le gallette. I rifornimenti non erano sufficienti per un viaggio così lungo. Il terzo giorno, acqua razionata: un bicchiere a testa. A metà giornata passa un aereo da ricognizione, un biplano perlustratore, li sorvola e li individua. Loro si sbracciano a più non posso, gridano. L’aereo fa un giro sopra i convogli, saluta e va via. Dopo due ore torna e lancia una tanica da venti litri, di quelle utilizzate per la benzina, piena di acqua e un sacchetto con della farina. Prendono la paiola per il cambio olio, staccano due sponde del camion, che sono di legno, accendono un fuoco e bollono acqua e farina per sfamarsi. Per girare il miscuglio usano un semiasse di ricambio, metallico, che però nell’acqua bollente, si surriscaldava e scottava le mani. Così il soldato addetto alla cucina levò dalla tasca la pezzola per il naso, in modo da tenerlo senza bruciarsi. Peccato però che la pezzola gli cascò dentro il paiolo e finì nella minestra. Una volta ripescata papà rideva e diceva, mai visto un fazzoletto così bianco! Comunque quel che non ammazza ingrassa, anche se c’era poco da ingrassare. Mangiarono e si tolsero la sete, l’acqua sapeva di benzina, ma alternative non ne avevano.
Il giorno dopo arriva un cingolato veloce con mille litri di benzina. Rifornimento e ripartenza. Durante il viaggio il tenente avvisa mio padre e gli dice, guarda che ho visto che nella gola sparavi in alto o in basso, se lo rifai ti mando alla corte marziale. Arrivano ad Addis Abeba, allestiscono il campo. Il tenente grida, mio padre a testa china.
- Dov’è quello che non ha mira?
- Signor tenente, non ce la faccio, sono persone.
- Come ti chiami, soldato?
- Cervi Primo, signore!
- Cervi, prendi una pala e fammi una buca di quattro per quattro, profonda un metro.
Il sole era alto, bruciava, Per due giorni scavò la buca. Una volta finita di scavare, il tenente gli ordinò: ora la ricopri! E papà a metà lavoro, ci cascò dentro svenuto e si risvegliò, non si sa quanto tempo dopo, in una specie di pronto soccorso. Dopo qualche giorno ritornò in servizio.
Aveva parlato con il maresciallo durante il viaggio e gli aveva detto che al paese, per vivere, faceva il fotografo e sviluppava le foto. Così gli chiesero di fotografare i nativi del posto che, lavorando alla base, dovevano avere un documento di identità. Primo prepara la camera oscura. Per lo sviluppo usava la luce del sole, filtrata attraverso un’apertura regolabile della tenda da campo. Scatta le prime foto e lo sviluppo non gli riusciva, il negativo gli veniva bianco. Non si capacitava. Dopo qualche tentativo si rese conto che la pelle nera degli etiopi nel negativo risultava bianca. Ci rise allora e ci rideva ogni volta che se lo ricordava e che lo raccontava.
Ci sono foto dei nativi, austeri e smarriti, donne con i piccoli, povera gente che per pochi centesimi lavorava nel campo, il tucul -la capanna circolare con tetto conico di argilla e paglia che gli italiani chiamavano “tuculo”- dove papà, con acqua tiepida e sale, curò il mal d’orecchio ad un bambino, la palazzina costruita per il comando, una bomba inesplosa -almeno quella non avrà fatto male a nessuno- immagini della naia da meccanico dell’esercito, camion militari e cingolati. Fotografie che mio padre ha conservato, insieme a quelle di famiglia e degli spettacoli viaggianti. E c’era una foto con lui, in Africa, sorridente, con una scimmietta dispettosa sulla spalla, che gli rubava il sapone e gli attrezzi per la barba. Amava gli animali. Nel dopoguerra, ce le facevano anche a noi le foto con una scimmia alle scuole elementari, chissà perché. Retaggio coloniale? Il tenente per fortuna venne trasferito alla colonna mobile e l’insubordinazione umana di papà passò in secondo piano. Fanculo il tenente!
Nel ‘36 con la conquista dell’Etiopia, finisce la guerra in Africa e papà torna a casa. Durante il viaggio di ritorno si era portato nel taschino una scimmia piccolissima che gli fu sequestrata al porto di Bari. Mio padre diceva che gli sarebbe piaciuto tornare in Africa, però in pace, da civile, che il mal d’Africa esiste. E pure la malaria, che contrasse e lo curarono col chinino. Farmaci e vaccini l’esercito ne aveva. La guerra lampo era finita e rimaneva nella retorica nazionale una boria di impresa, di efficienza militaresca, la vendetta sull’onta delle sconfitte del passato periodo coloniale, la nascita dell’Impero. Si cantava “Faccetta nera”. Delle nefandezze, dell’uso delle armi chimiche, del gas da parte dell’aviazione, dell’eccidio di Debra Libanòs, l’anno dopo la fine della guerra, nel ‘37, che ne sapevamo noi soldati, combattenti e reduci, italiani dell’Italia “fascistissima”?
A Casale, Primo ritrova la sua famiglia e la sua giostra: è da una parte, abbandonata, le sorelle non erano in grado di farla funzionare. Risistema tutto e per le sorelle inventa l’attrazione “foto-lampo”. Gliene aveva parlato il maresciallo che l’aveva vista a Parigi. Con una carabina si sparava ad un bersaglio, se si colpiva si produceva un’esplosione, si accendeva un flash, una fumata bianca si levava e la macchina fotografica scattava una foto. Spettacolo! Il magnesio per il flash mio padre lo ricavava limandolo a forza di braccia dai cerchi di aereo abbandonati in qualche deposito. Le sorelle si alternavano al banco del tiro e allo sviluppo nella camera oscura retrostante -papà insegnò loro la tecnica- per consegnare agli avventori la foto istantanea. Altro che Polaroid o Kodac instamatic! Una grande attrazione, un successo! La poetica inventiva dei giostrai. “Le masnà, con doe miseire, son cuntente... A sent che la poesia l’è tüta lì: fà l’univers con gnente”, diceva alle sorelle, in dialetto monferrino: “Le bambine con due miserie sono contente… Forse la poesia è tutta lì: fare l’universo con niente”. La famiglia si rimise in piedi e vennero anche momenti buoni.
Sennonché, l’ora segnata dal destino batteva -più che altro incombeva- nel cielo della nostra patria e Mussolini, affacciato e gesticolante da Palazzo Venezia, davanti a una folla inneggiante e plaudente, il 10 Giugno del 1940 dichiara guerra a Francia e Inghilterra. “L’Italia, proletaria e fascista, scende in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell’Occidente” a fianco della Germania nazista. Il popolo adunato in piazza acclama lungamente all’indirizzo di Hitler. “La parola d’ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti: vincere e vinceremo, per dare finalmente un lungo periodo di pace con la giustizia, all’Italia, all’Europa, al mondo. Popolo italiano! Corri alle armi, e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore!”. E il popolo prorompe in altissime ovazioni rivolte al Duce. È la seconda guerra mondiale. Non bastava la dittatura fascista, ci furono le leggi razziali, la ferocia del nazismo, i campi di sterminio, l’Olocausto, la morte e la distruzione. Papà riparte soldato.
Lui ricorda alcune tappe della guerra: di nuovo in Africa, in Libia, a Tripoli e Misurata, poi in Grecia -a cui non spezzammo le reni, anzi- e in Albania, dove sparerà il suo primo colpo di moschetto a un’anatra, perché non arrivavano i rifornimenti e avevano fame. Seguirono anni orribili che la memoria cancella o confonde per pietà verso se stessa. Intanto si avvicinava l’8 Settembre 1943. L’Armistizio. I tedeschi, da alleati diventano nemici. L’esercito italiano è allo sbando. La sera Primo mangiava alla mensa accanto a militari e ufficiali tedeschi, il giorno dopo dai tedeschi era stato disarmato, preso prigioniero e fatto marciare verso il confine con l’Italia per dodici o quindici giorni. Il ricordo si fa confuso. Infatti da qui in avanti i suoi racconti sono brevi e interrotti spesso dalle lacrime. Forse non voleva renderci partecipi più di tanto di quella tragedia, quasi a tenerci lontani dal dolore e dal rancore. Comunque la parte più dura e triste deve ancora venire.
Quella marcia della prigionia me la raccontò in più episodi. Uno è questo: quando erano in cammino, all’incirca a metà strada, un suo commilitone, l’amico che gli aveva insegnato a cucinare l’agnello in Grecia, si fermò per mettere uno straccio dentro lo scarpone sfondato. Un tedesco lo vide, lo tirò fuori dal gruppo trascinandolo per il colletto e gli sparò in testa, come monito a chi intendesse sedersi o fermarsi, rallentando la deportazione. Si moriva così per niente, per ferocia. Si asciugava gli occhi e mi diceva, continuo un’altra volta, Fabrizio, ora no. Domani, forse.
Spalato, Zagabria e Lubiana, queste erano le tappe dove incominciava a rendersi conto e temere che non sarebbe più tornato più a casa. Arrivano in un centro di smistamento dei deportati. Si scorgevano in lontananza dei camion, alcuni con centine e tela arrotolata, più dietro altri, tutti in lamiera, senza aperture. Anziani, donne e bambini venivano spinti, sollevati e stipati su questi camion blindati. A questo punto si fermava, abbassando gli occhi. Ora basta mi diceva, lascia perdere, sono cose che non voglio ricordare. Dopo parecchi giorni chiesi: ma papà, te in che camion ti misero? Rispose: sono stato un meccanico, quando vidi che i camion blindati avevano una deviazione del tubo di scarico, azionabile con una farfalla, che finiva dentro i cassoni, mi spostai nella fila di quelli telati, trascinando con me il mio maresciallo. Che però era piccolo di statura e magro e i tedeschi lo costrinsero nella fila dei bambini, delle donne e dei vecchi. O morte per gas dei più deboli o deportazione nei campi di lavoro in Germania.
Mi diceva di Lipsia e Dresda. Aveva dei vuoti di memoria circa i posti dove fecero diverse soste. Mi diceva che lo portarono a lavorare, ma lui si rifiutava di farlo per loro, i nazisti. Allora lo picchiavano, non gli davano da mangiare e alla fine si arrese. Lavorava in una fonderia di lamiere grandi e spesse. Un giorno una di queste gli cascò sulle gambe. Per fortuna, un troppolo di legno limitò il danno a un ginocchio che fu solo un poco schiacciato. Si finse svenuto e lo buttarono fuori dal capannone, come un morto. Era il febbraio del ‘45, per qualche mese un infermiere del campo di lavoro, un giovane che stava vicino a Scandicci, lo nascose nei locali spazzatura, dietro ad alcuni cassoni inutilizzati. Gli fece una steccatura al ginocchio e lo lasciò alla sorte. Passavano i giorni e sai cosa mangiavo? Rufolavo nei bidoni della spazzatura per cercare qualcosa di ancora commestibile. Spesso m’imbattevo in resti umani, dita e scarti putrefatti. Mio padre era un uomo robusto, ossa grosse, ottantacinque chili, alto un metro e settantatré. Ormai gli erano rimasti addosso a malapena una quarantina di chili. Una notte ci fu un bombardamento fortissimo su Dresda. Dal campo sentivamo gli scoppi, vedevamo i bagliori e gli incendi. La città fu distrutta. La Germania aveva perso la guerra. I superstiti del campo, allo sbando, cercavano di sopravvivere e tornare a casa.
Ricordo che, non so come, transfuga dal campo di Dresda, mi ritrovai seduto su un predellino del carro merci di un treno in movimento. Alla stazione di Milano, dopo qualche giorno, vestito da tedesco, venni colpito dal calcio del moschetto di un partigiano che mi aveva preso per un crucco mangia patate. Il cappotto militare tedesco l’avevo preso per ripararmi e confondermi nel fuggi fuggi generale. Italiano! Prigioniero italiano, gridai.
Finii al Niguarda, l’Ospedale di Milano, dove la mia sorella più piccola, Velia, mi aveva rintracciato attraverso missive e contatti vari con la Questura. I medici le dicevano che urlavo e piangevo e ci sarebbe voluta una terapia elettroconvulsivante. Spesso i dottori parlano difficile, specie con la povera gente, con le persone semplici. Mi fecero l’elettroshock per calmarmi -dissero- e dimenticare. Da qui le amnesie, i successivi vuoti di memoria. Ma non dimenticherò mai quando i tedeschi, nel campo di prigionia vicino a Dresda, spalmavano la merda della mia cella sulla galletta e me la tiravano gridandomi: se lavori niente “sciàise”. Che si pronuncia così e si scrive “scheiße”, ma vuol dire lo stesso “merda”. Dopo l’elettroshock mi tennero quasi due mesi in Ospedale. La terapia era duecento grammi di zucchero al giorno e pasti adeguati, altrimenti andavo in dissenteria. Ancora sciàise. Due guerre che bruciano la vita, l’elettroshock che brucia la mente, offusca i ricordi. Altra vita che si perde. E, tra il servizio di leva e le guerre, nove anni dati, senza ricevere un grazie. Solo scariche elettriche. Cos’altro deve sopportare un uomo? Quanto altro spreco? Quale altra barbarie?
Tornato a Casale dopo qualche mese, mio padre si rese conto che la giostra con calessi e asinelli e l’attrazione foto-lampo, erano andati distrutti durante la guerra. Lo zio che faceva i carretti era morto, come il falegname degli asinelli. Mafalda, la sorella più anziana, si accompagnò con un tedesco rimasto in Italia. Itala sposò un brav’uomo: dalla loro unione nel ‘46 nacque Riccardo e nel ‘48 Angelo, i miei amati cugini. Il dopoguerra fu difficile per tutti. Primo era alla fame, però, come sempre, aveva idee. Da un raccoglitore di stracci e cianfrusaglie trovò tanti vasetti di vetro a poco prezzo e costruì un gioco a premi. Lanciavi delle palline e, se centravi il vasetto, vincevi qualcosa. Un pupazzetto o, magari, un pesciolino rosso in un sacchetto trasparente pieno d’acqua. Era finita da poco la guerra e la gente doveva ricostruire case e vite, ma aveva anche voglia di cose semplici, di svagarsi, di uscire, di condividere un po’ di serenità, di stare in pace.
Guardo l’orologio. Aspetto, quant’è che aspetto? In casa c’è silenzio. La notte passa insonne. Il cielo, a guardarlo dalla finestra, è coperto da nuvoli neri, non si vedono né luna, né stelle, mentre scende una nebbia leggera. È buio e non succede niente. Niente di niente. Siamo prigionieri del tempo che rimanda e fonde i ricordi.
Gloria, mia mamma, o meglio colei che sarebbe diventata mia madre, veniva da una famiglia benestante romana. Studiava ragioneria. Vivevano in una bella casa in via del Corso, a Roma, ma solo con il padre, Armando Volpi, artista, fondatore di riviste letterarie, antiquario e gallerista, scrittore e poeta romanesco, “il poeta del cuore”. Amico di Ettore Petrolini, nientemeno. Un sacco di cose, sempre meglio che lavorare, avrebbe detto Vittorio Gassman, molti anni dopo. Armando, che in seguito si trasferì a Milano, non si era mai voluto sposare con la sua compagna Caterina, la mia futura nonna, da cui pure aveva avuto Gloria e altri quattro figli. Così Caterina s’era stufata e un bel giorno, poco prima della guerra, se n’era andata a Torino. Una donna indipendente, determinata. A Torino c’era la sua mamma, la mia bisnonna, che lavorava in una fabbrica di dolci e raccontano che, quando morì, esposta nella bara, odorava di vaniglia.
Nel ‘48 anche Gloria lascia Roma e va a Torino dalla madre Caterina. Pure Caterina era un’artista, però più bohémien del suo compagno romano. Era una bella donna, ballerina al Teatro Regio ed era approdata all’avanspettacolo, al varietà, come usava a quel tempo. Anche Gloria era bella, aveva il diploma di ragioneria, meno adatto per l’arte, ma una voce molto intonata, e sua madre, che l’accompagnava al piano, la introdusse nello spettacolo come cantante. Gloria e Caterina conducevano una vita povera, facevano fatica a mettere insieme il pranzo con la cena.
Una sera mio padre Primo andò a Torino al cinema, c’era una rivista di avanspettacolo e notò mia mamma che si esibiva sul palco. La sentì cantare: un usignolo! Con Gloria fu amore a prima vista. Un’attrazione lampo, come alla Fiera! All’uscita l’aspettò per parlarle. Papà, uomo gentile, osservatore e premuroso, la sera dopo si ripresentò con un paio di scarpe da donna nuove, perché aveva visto che quelle di Gloria erano sfondate. L’anello venne dopo. Si frequentano e nel ‘49 si sposano. Sono esercenti di spettacolo, ma viaggiante, girano le Fiere per vivere. Nel ‘50 nasce mia sorella Patrizia e nel ‘55 il sottoscritto, Fabrizio.
Al matrimonio di papà Primo e mamma Gloria viene anche il fratello di mia mamma, Agostino, e vengono le sorelle di mio papà, tra le quali Velia, la più giovane, poco meno che ventenne. Velia e Agostino, che aveva lasciato Roma e la casa di suo padre Armando, si conoscono e da lì a poco si sposano anche loro. A quei tempi spesso l’amore era una cosa rapida e certa. E che destino, che intreccio la vita! Il mio papà ha una sorella che ha sposato il fratello di mia mamma. I loro figli, oltre che cugini, sono come fratelli per me, per via della doppia parentela. Da Velia e Agostino nascono Armanda, Adriana e Antonello. Era il dopoguerra e c’era la fame. Lo zio Agostino non trovava lavoro, perciò con sua moglie, la zia Velia, batteva le Fiere con i giochi a premio. Finché, dopo un po’ di anni, fece carriera nell’Anesv, l’Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti, tornò con la famiglia a Roma dove ha vissuto, e fu eletto Presidente. Così quella divenne la sua professione: rappresentante e dirigente della categoria. Noi, le nostre famiglie, veniamo da lì. Siamo stati giostrai, siamo gente di spettacolo viaggiante di anima e mestiere. Giriamo piazze e strade d’Italia, come gli ambulanti che fanno i mercati, ma, diversamente dagli ambulanti che vendono cose solide, camicie, scarpe, cinture, casalinghi, eccetera, noi vendiamo cose leggere, spettacoli, giochi, premi, giostre, divertimenti. La gioia di un momento. Viaggiamo con le nostre attrazioni e la vostra fantasia.
Mia sorella Patrizia quando arriva all’età delle commerciali, va in collegio a Saluggia, in provincia di Vercelli, per poter studiare. Io arrivo a fatica a cinque anni di vita. Mi avevano dato per spacciato a causa di un blocco renale. Quando avevo sei anni mamma decide di prendere casa a Como dove, in Comune, conosciamo delle brave persone. Vado a scuola, ho ancora problemi renali. Anche mia sorella torna dal collegio e studia a Como. Papà Primo gira da solo le Fiere con i suoi giochi a premio e ci mantiene. Però il destino -non più quello delle guerre, delle ore solenni patriottarde, ma quello che sempre attraversa la nostra esistenza- vuole che un’angina pectoris e una grave dilatazione dell’Aorta lo mettano a rischio di vita. Allora andammo ad Ancona dove si sapeva di un luminare, un cardiologo. Il professore, visitato mio padre, disse alla mamma che i patimenti della prigionia e le paure gli avevano devastato il corpo e la mente. Signora ha due figli, si prepari perché, al primo attacco di cuore più forte, suo marito non ce la farà.
Primo era un uomo di grande fede e vicino ad Ancona c’è Loreto. Ci andiamo tutti. Nel Santuario della Madonna nera è custodita la Santa Casa dell’apparizione di Nazareth, trasportata, si dice, dagli Angeli. Mio padre, che ormai camminava a fatica e con il fiato corto, solo aiutandosi con il bastone, lo appoggiò alla parete e fece, in ginocchio, il giro della Santa Casa. Durante il percorso ebbe un attacco e un malore. Ma si riprese e uscì sulle sue gambe, dimenticando il bastone. Una grazia? Il destino? Chi può saperlo. Un dottore, più avanti, mi disse che forse la grande emozione e la fatica durante il percorso in ginocchio potevano avergli procurato un trauma leggero ad una parte del muscolo cardiaco con la conseguente riduzione della pressione sanguigna. Per questo “assestamento” probabilmente la valvola aortica e l’arteria dilatata, pur malandate, tenevano. La vita e la morte per me sono un mistero. Come la fede. Mio padre ha vissuto ancora vent’anni ed è morto di tumore, forse a causa di una cattiva e ritardata diagnosi. Ma non di cuore.
Comunque, vista la salute malferma di papà, mamma Gloria decise di tornare sulle Fiere con le attrazioni a premi e noi figli si cambiava scuola tutti i mesi. All’età di otto anni, ho subito un trauma affettivo enorme. La seconda figlia di Agostino e Velia, la mia adorata cugina Adriana, quindicenne, una sorella per me, stava andando a scuola. Una volante della Polizia stava inseguendo un’auto di malviventi. Per fermarli sparano alle gomme, ma un proiettile prende il cerchione, viene deviato sull’altro lato della strada e colpisce Adriana alla femorale, portandole via la vita in poche ore. Le disgrazie non vengono mai sole: la sorella più grande, Armanda, morirà di un tumore. È una cosa tremenda e innaturale che i genitori sopravvivano ai figli. Spesso penso che la sorte si accanisca su di noi, sulla nostra gente già tanto provata e spezzi le persone più buone e innocenti. Dice che Dio le voglia con sé, ma è difficile darsene pace e ragione.
Aspetto. Guardo il cellulare: non ci sono novità. Possibile? Guardo fuori, dal vetro appannato della finestra. È ancora buio, si vedono ombre, si sentono rumori ovattati, giù nella piazza. Un autobus ha acceso i motori. Rimango un po’ in piedi. Forse qualcosa sta per accadere. Sono stanco, nonostante abbia fatto poco nelle ultime ore. È l’attesa che è snervante e spossante. Mi siedo di nuovo in poltrona. Ho acceso la tele e lascio scorrere le immagini senza il sonoro. In casa dormono. Almeno anch’io fossi riuscito a prendere sonno nel mio turno di quattro ore, come mio padre di sentinella! Ma niente, non riesco, è troppa la tensione. Aspettare, aspettare… Si aspettano eventi nel corso della vita, quello che mi successe a diciotto anni, però non me l’aspettavo di certo. Fu un fatto terribile che mi sconvolse.
Era il 1973, abitavo ancora a Torino, ma ci trovavamo alla Fiera di Lucca dove avevamo un’attrazione. Però dovevo venire a Pontedera a sentire di un terreno in affitto per la roulotte, dove avremmo dimorato perché, poco dopo, ci sarebbe stata la Fiera di San Luca. Eravamo in Vespa, io e mio cognato, il marito di mia sorella Patrizia. Guidava lui. Sulla via di ritorno per Lucca, a Colle di Compito, dietro una curva, sul nostro senso di marcia, ci imbattemmo in una BMW parcheggiata, affiancata da un’Alfetta, ferma in mezzo alla strada. Un pullmino, proveniente dal lato opposto, non riusciva a passare per la ristrettezza della carreggiata. Uno sbarramento di automezzi! Ce li trovammo davanti all’improvviso, la strada era bagnata, la vespa, sulla frenata sbandò e andammo a sbattere. Io, sul sedile posteriore, fui catapultato oltre il pullmino. Il casco mi volò via e pure una scarpa. Ricaddi pesantemente al suolo, sbattendo la testa e la schiena. Persi conoscenza. Ero come morto. Invece a mio cognato, alla guida della Vespa, andò meglio: si troncò soltanto un dito. Per un attimo ripresi conoscenza, dolorante e frastornato, sull’ambulanza che mi portava all’ospedale. La sola cosa che vidi fu un piccolo crocifisso di legno appeso nell’ambulanza: lo notai perché gli mancavano un braccio e le gambe, per questo mi rimase impresso. Poi sprofondai di nuovo in stato d’incoscienza. Rimasi così per diversi giorni, risvegliandomi all’Ospedale. E quello che ricordo ancora è una vista dall’alto dell’incidente: io che volo, cado e resto a terra, l’ambulanza e una macchina della polizia che arrivano sul posto. A volo d’uccello vedo che mi soccorrono, cercano di non muovermi troppo e mi caricano, tutto imbragato, sulla barella. Una visione, un sogno, un incubo? Nell’urto, senza contare un piede rotto e ferite varie, mi procurai un trauma cranico e mi fratturai la colonna vertebrale. Se i soccorritori non fossero stati accorti, adesso molto probabilmente sarei su una sedia a rotelle. Con diversi ricoveri, stetti complessivamente settantaquattro giorni in Ospedale. Portavo un busto costrittore, una tortura! Quando mi alzarono non riuscivo più a camminare, così altri sei mesi con il busto e una difficile, faticosa e dolorosa riabilitazione. Ancora oggi ho problemi alla schiena. Ed eccomi qua. Nella lunga degenza ospedaliera ho sempre pensato di essere rimasto, dopo l’incidente, in una specie di limbo, sospeso tra la morte e la vita. Qualcuno lassù mi ha voluto bene oppure la vita me ne ha voluto. Chissà. Ma forse è la morte che non mi ha preso, non era la mia ora e mi ha lasciato andare. Fatto sta che quel crocifisso trent’anni dopo, da uno sfattino, dove cercavo dei pezzi di ricambio per l’auto, l’ho ritrovato dentro un’ambulanza in demolizione. Solo una coincidenza? Era la “mia” ambulanza ed era proprio lui, senza un braccio e le gambe, povero Cristo! Lo tengo ancora nella mia macchina, penso che mi assista. Mi fa compagnia. Ho votato comunista e creduto in Dio.
Alla fine mi rimisi in piedi e, dopo svariate visite e diversi anni, mi riconobbero il 50% di invalidità. Con la mia famiglia continuavamo a campare come giostrai, seguendo le Fiere di paesi e città. Nel ‘74 dopo la Fiera di Torino, dove allora avevamo la residenza, venni a sapere di un corso di formazione per disabili o persone con riconosciuta invalidità. Il corso era per acquisire capacità e competenze per adattare la propria disabilità alla vita e al lavoro.
Nel 1978, mio padre Primo, che da tempo cercava una sistemazione più stabile, funzionale e centrale per le manifestazioni fieristiche, compra una casa a Pontedera, dove traslochiamo e prendiamo la residenza. Papà continua il lavoro nelle Fiere e tutti diamo una mano come possiamo. Intanto alla Piaggio si presenta una possibilità di lavoro, faccio domanda e dopo un po’, i primi del 1980, vengo assunto. Quel corso di Torino mi sarà utile. A volte dopo cose terribili vengono cose buone, come se la vita volesse compensarci del nostro destino avverso con qualche avara fortuna. Anche se in fabbrica non sono state tutte rose e fiori: licenziamenti, cassa integrazione, lotte sindacali. I tempi cambiano e i padroni sono padroni. Ma non è finita qui. Alla Piaggio conosco Gabriella che lavora in verniciatura. Ci si vuol bene, siamo innamorati e ci sposiamo subito, nell’Ottobre dell’80. Poi tutto prende a scorrere nelle nostre esistenze. E a ripercorrere le cose ora, mi sembra che, con l’amore, il nostro tempo abbia avuto un’accelerazione sorprendente. Nell’Aprile dell’82 nasce nostra figlia Valentina. Gabriella purtroppo ha i primi sintomi della sclerosi multipla che l’affliggerà durante la vita. Troppa fortuna ingelosisce il destino. Gabriella si impegnerà nell’AISM, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che lavora per la rappresentanza e i diritti delle persone colpite, nonché per la promozione della ricerca scientifica di contrasto a questa malattia degenerativa del sistema nervoso centrale.
Nel 1983 muore Primo, il meccanico, il fotografo, il giostraio, l’esercente di spettacolo viaggiante e molto altro. Aveva settantaquattro anni. Era mio padre. Ha fatto in tempo a vedere nascere sua nipote Valentina, a prenderla in braccio. Mamma Gloria, ragioniera diplomata e cantante, muore nel ‘90, a sessantaquattro anni. Così miei genitori se ne sono andati, con la loro epoca, la dittatura, la guerra, la fatica e la voglia di vivere, il dolore e la gioia. La loro resistenza. Resta un senso di perdita, una condizione di orfani, l’orfanità. E questa memoria viva di loro dentro di me. Dentro ognuno di noi. Valentina si laurea, è medico, si sposa, nascono due figli. Siamo nonni.
E adesso finalmente l’attesa è finita, in sala d’aspetto si apre la porta, un’infermiera annuncia che è ora. Mio genero ci telefona, Gabriella rimane con i bimbi che dormono ancora e io mi precipito all’Ospedale. Dopo sei ore di travaglio, alle prime ore del giorno, Valentina partorisce e nasce Lorenzo. Il terzo figlio e nipote. È il quattro Febbraio del 2025. La madre e il bambino stanno bene. Il bimbo pesa oltre quattro chili. Non voleva uscire, capace aveva già capito che questo è un mondaccio e c’ha pensato un po’, s’è trattenuto, aspettava anche lui. In questa attesa mi hanno accompagnato i ricordi dei miei cari, papà Primo, mamma Gloria e gli altri che affollano la memoria. Primo, il capostipite, e Lorenzo, l’ultimo nato: tutto nasce, muore, rinasce. È un’attrazione, un can-can, un gioco a premi la vita, uno spettacolo viaggiante, una canzone. Un giro di ballo e di giostra.
Marco Celati
Pontedera, Marzo 2025
P.S. Questo racconto non è di chi l’ha scritto, ma di chi l’ha raccontato. Tranne qualche citazione, è tutto vero e io sono un ladro di storie, senza troppa fantasia, oltretutto recidivo. Ma un ladro gentiluomo, se così posso dire: rubo a chi racconta per donare a chi legge. E lo faccio chiedendo il consenso al narratore. In questo caso a Fabrizio, per il padre Primo, mamma Gloria e i suoi cari. Ma Fabrizio ha fatto di più che raccontare a voce: molte frasi sono sue, messaggiate al cellulare e riportate nel testo. Quindi, alla fine, si tratta di un racconto, più che sottratto, preso in prestito e scritto a quattro mani. Così il furto è meno grave e forse sarò assolto perché il fatto non costituisce reato. La breve citazione dialettale è tratta da una poesia di Milo De Angelis intitolata "Staseira", che altre volte ho raccolto. È in dialetto monferrino, che era anche quello di Primo, dalla raccolta "Distante un padre". Troppe coincidenze per non raccoglierle ancora.
Marco Celati